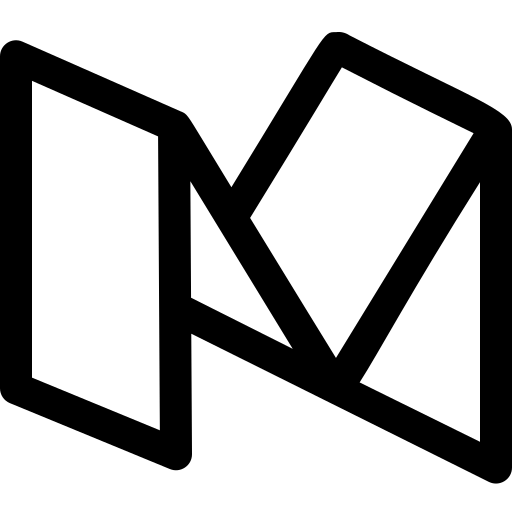Anche quando hanno ottenuto un certo successo durante la loro carriera, le drammaturghe italiane appaiono di rado in manuali di storia del teatro o in antologie di testi teatrali. Eppure per tutto il Novecento le donne italiane hanno scritto e anche recitato, ma solo un’appassionata, lunga e spesso frustrante ricerca in archivi e biblioteche consente di recuperare la loro produzione e apprezzarne l’importanza.
D’altra parte, scrollare la polvere della storia e riportare alla luce i nomi e le opere delle donne che hanno scritto, pubblicato, rappresentato, è doveroso ed essenziale per poter ricostruire un panorama del Novecento teatrale italiano in cui la presenza femminile non venga ignorata o addirittura definitivamente cancellata.
Andando dunque alla ricerca di donne che hanno fatto teatro prima degli anni ’60-’70, troveremo alcuni nomi di autrici che sono state famosissime durante la loro vita – per esempio, Paola Riccora (1884-1976) e Anna Bonacci (1892-1981) e quelli di decine e decine di altre autrici le cui opere avevano acquistato popolarità presso pubblici limitati e sono ora totalmente dimenticate. Che cosa scrivevano? Spesso commedie per il teatro educativo cattolico e radiodrammi.
Prima dell’avvento della televisione, il teatrino parrocchiale o della scuola costituiva un mezzo di aggregazione per i gruppi filodrammatici e per il pubblico locale. In ambiti cattolici, in cui si preferiva mantenere una separazione tra i sessi, i gruppi teatrali erano quindi costituiti da soli ragazzi o sole ragazze. La necessità di trovare dei testi con cast esclusivamente femminile ha spinto molte autrici a creare commedie per ragazze, diffuse poi attraverso pubblicazioni specifiche come Scene femminili o Teatro delle giovani.
Il radiodramma è stato un genere teatrale molto popolare in Italia dagli anni ’30 fino ai primi anni ’60, per poi andare in declino con l’ascesa della televisione. Era una tecnologia poco costosa (data la mancanza di palcoscenico, messa in scena o costumi) e quindi costituiva un’ottima pedana di lancio per nuovi autori o autrici, che poi pubblicavano su riviste di teatro, come Palcoscenico e Ridotto.
Saggi
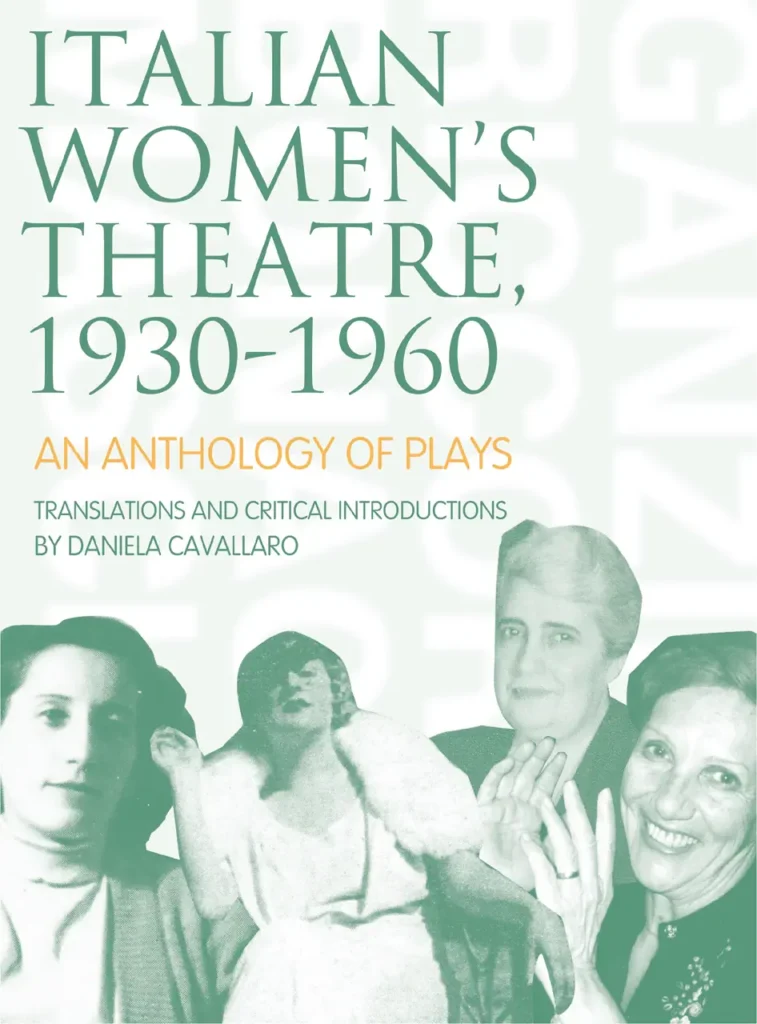
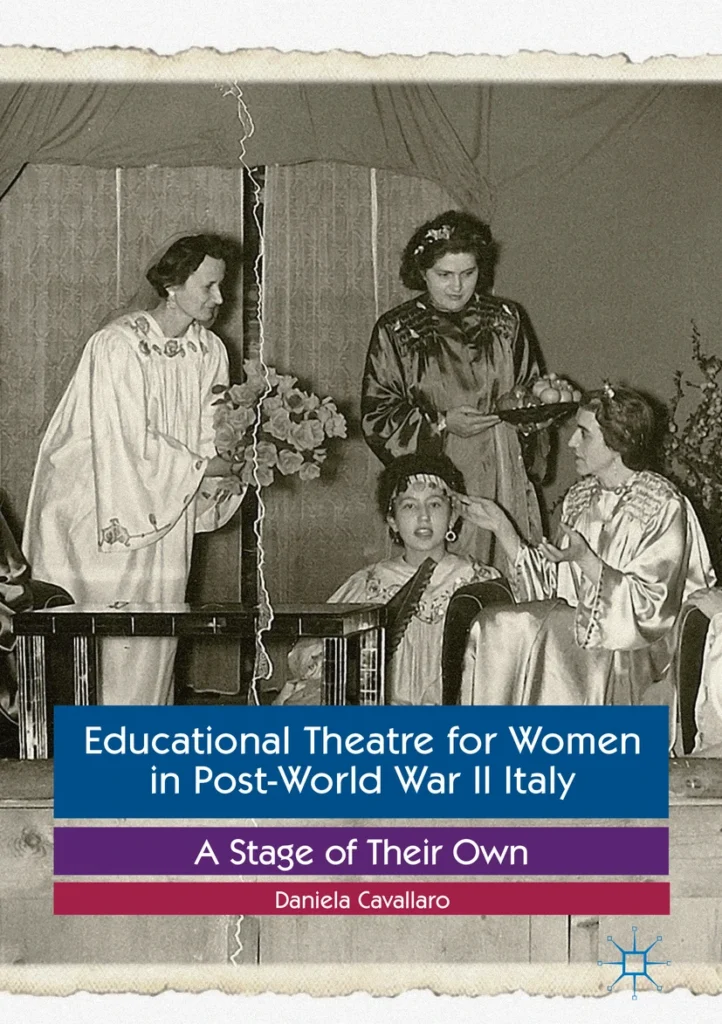
Cavallaro, D. (2019) Alla ricerca delle drammaturghe perdute. Itinera, n. 18 (soprattutto le pagine 25-26).
Cavallaro, D. (2019). “After Filumena: illegitimacy and paternity in 1950s Italian women’s theatre”, Italian Studies (soprattutto la sezione su Un bambino dice ‘grazie’).
Cavallaro, D. (2017). Educational theatre for women in post-World War II Italy: A stage of their own. London, UK: Palgrave Macmillan (soprattutto i capitoli 6 e 7, sulle commedie pubblicate su Scene femminili).
Cavallaro, D. (2017). “From fairy tale to hysteria: Women in Italian theater in the early 1950s”. In V. Picchietti, & L. A. Salsini (Eds.), Writing and performing female identity in Italian culture (pp. 127- 151). Cham, Switzerland: Springer International (soprattutto le pagine su Vigilia nuziale).
Cavallaro, D. (2016). “Wellington 2013 – Of marriages and happy endings: A reading of Clotilde Masci’s Vigilia nuziale”. altrelettere, 1-21.
Cavallaro, D. (2011). Italian Women’s Theatre, 1930-1960: an anthology of plays. Bristol: Intellect Ltd. (soprattutto le pagine 245-326).
Cavallaro, D. (2010). “Catholic Theater for Women in Post-War Italy: Education, Morality, and Social Change”. In K. Wetmore (Ed.), Catholic Theatre and Drama. Critical Essays (pp. 125-140). Jefferson, NC: McFarland (soprattutto la sezione su Qualcuno al timone).
Cavallaro, D. (2006). “Scene femminili: Educational Theater for Women”. In P. Morris (Ed.), Women in Italy 1946-1960. (pp. 93-107). Palgrave (soprattutto la sezione su Solitudine del cuore).
Cavallaro, D. (2004). “Ritratti di donna: il teatro di Clotilde Masci”. Rivista di Studi Italiani, XXII, 123-141.
Cavallaro, D. (1999) “Drammaturghe italiane degli anni ‘50”. Italian Culture XVII, 1: 141-152.